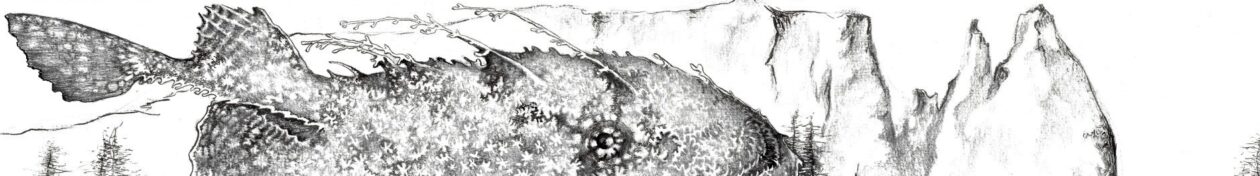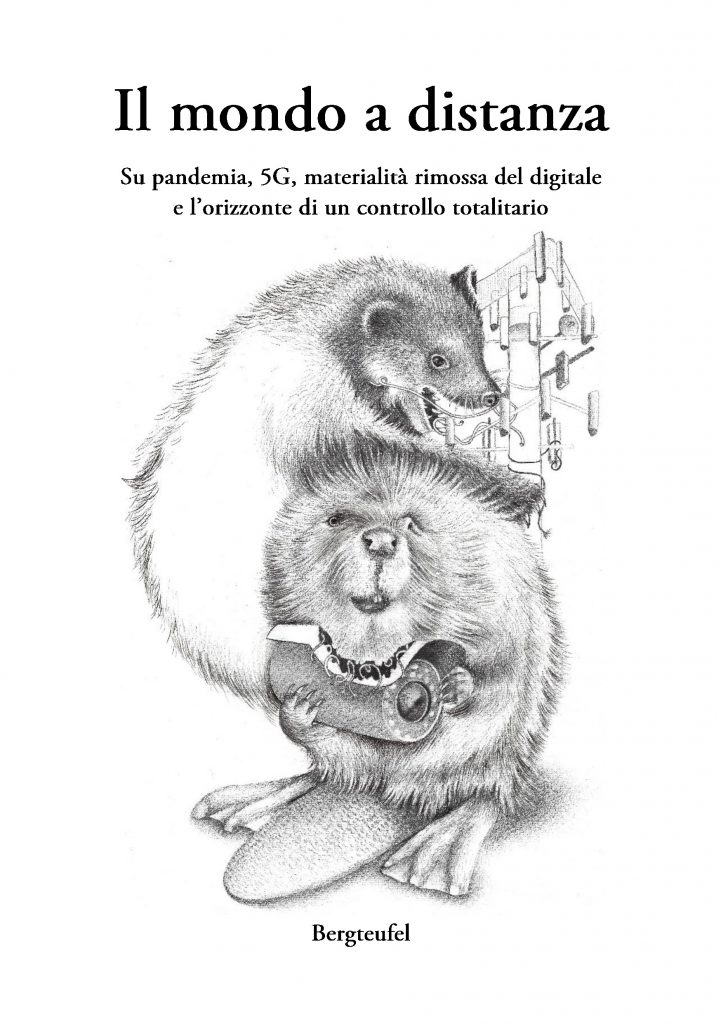Di seguito il testo dell’opuscolo, qui il file pdf stampabile (A5). Come si dice nella premessa, ci si propone semplicemente, attraverso alcune letture, esempi e considerazioni, di suggerire l’urgenza di prendere in mano il tema dell’impatto della tecnologia e in particolare delle tecnologie informatiche – rete 5G in testa – in termini di controllo, e di quel che si cela dietro la loro presunta immaterialità. Per richieste di copie cartacee, osservazioni o altro si può fare riferimento all’indirizzo email bergteufelbz@autistici.org. Il disegno in copertina è di acquadicarciofo.
Premessa
Il testo che segue non vuole essere un’analisi sistematica e complessiva della questione dell’impatto attuale e futuro delle tecnologie informatiche in termini di controllo – e di quel che si cela dietro la loro millantata immaterialità. Si propone semplicemente, attraverso alcune letture e osservazioni abbastanza sparse e procedendo per esempi scelti fra i molti disponibili, di porre all’attenzione il tema, per suggerire l’urgenza di assumere come una priorità l’opposizione e l’attacco contro queste tecnologie e coloro che le promuovono.
Ci occuperemo qui soprattutto di un gruppo di tecnologie dell’informazione fra loro interdipendenti – a partire dalla rete 5G, l’infrastruttura che permetterà il funzionamento di tutte le altre. Sarebbe però altrettanto importante approfondire il tema ad esempio dei lati oscuri di altre tecnologie vendute come green e dell’impossibilità di un capitalismo “sostenibile”, così come quello della vera e propria religione tecnologica e scientista imperante, e così come la critica radicale della tecnologia in generale, che, lungi dal rappresentare – con buona pace degli accelerazionisti “di sinistra” – un “neutro” progresso delle conoscenze umane alla conquista di strumenti utilizzabili in un senso o in un altro a seconda dell’organizzazione politica, andrebbe letta come corpo fisico dell’ordine sociale, inseparabile da un apparato che inevitabilmente richiede divisione del lavoro (anche nel senso di divisione internazionale, neocoloniale, del lavoro) e un’organizzazione sociale complessa e gerarchizzata, e che tende – come insegna la storia del Novecento – a distanziare progressivamente gli uomini dal senso delle proprie azioni, e ad espropriarli delle loro capacità umane per renderli sempre più dipendenti dall’apparato stesso. Come è stato scritto, «non c’è nulla di questo nuovo modo di produzione informatico [di cui ci] si possa riappropriare, ma l’esigenza vitale di lottare e distruggere questa “recinzione digitale globale” e le relazioni sociali che produce».
Contact tracing
La pandemia è stata e continua ad essere, com’era prevedibile, un’occasione per un’accelerazione nell’introduzione di nuove tecnologie di controllo, presentate come un grande servizio in una situazione emergenziale. Nei giorni della massima diffusione del contagio l’Ansa prevedeva che «il tracciamento da parte di app per individuare assembramenti o contatti con persone infette è cosa di giorni, ma il futuro non ha limiti. Le app potrebbero spingersi a individuare comportamenti a rischio o sintomi pericolosi, a segnalare tempi di attesa per i mezzi pubblici e per l’ingresso nei supermercati. In base ai dati virtuosi raccolti, alle app potrebbe essere affidata l’ultima parola per l’ingresso in luoghi di aggregazione». Se in Italia il varo dell’app Immuni si è risolto in una farsa, i modelli presentati anche da noi come esempi da imitare sono stati quello sudcoreano – dove i dati sugli spostamenti degli ultimi 14 giorni di ogni paziente infetto, tracciati attraverso smartphone, carte di credito, videocamere ecc., sono stati pubblicati su appositi siti – e, con qualche distinguo, quello cinese. In molte città cinesi, per accedere a trasporto pubblico, negozi e uffici è necessario mostrare un codice QR (praticamente un codice a barre, che può essere scansionato per un controllo in tempo reale) sul proprio smartphone, che si aggiorna automaticamente in base alla cronologia dei propri spostamenti e ai possibili contatti con persone positive, passando da verde a giallo o rosso se si rende necessario un periodo di isolamento. Di fatto, in alcune città è divenuto impossibile circolare senza avere con sé uno smartphone in grado di tracciare i propri movimenti e mostrare questo codice. I giornali hanno riportato, fra il preoccupato e l’ammirato, vari esempi del livello di controllo già in atto in Cina, come quello di un uomo che, appena tornato da una zona considerata ad alto rischio di contagio e “invitato” a restare a casa, è stato contattato dalla polizia e dal suo datore di lavoro – avvisato dalle autorità – perché una telecamera con riconoscimento automatico l’aveva individuato in giro. Oltre all’implementazione di tecnologie di controllo come queste e le altre che sono state prospettate nei giorni del lockdown (droni, braccialetti elettronici ecc.), la pandemia costituisce anche, attraverso videochiamate, smart working, didattica a distanza, un formidabile moltiplicatore della benzina necessaria all’intelligenza delle macchine per affinarsi, ovvero i dati – dai discorsi alla mimica facciale, come vedremo – ricavati da tutti i nostri comportamenti online. Infine, la ripresa (vedi Recovery Plan) sarà occasione di massicci investimenti proprio in digitalizzazione e nelle infrastrutture che la permettono come la rete 5G.
Ovviamente, spesso i risultati reali delle tecnologie presentate non si rivelano all’altezza delle proiezioni, o la loro introduzione va incontro a ostacoli di vario tipo e vengono accantonate. Tuttavia, ci sembra evidente che ci troviamo di fronte a una profonda ristrutturazione tecnologica del dominio e del controllo sociale, per comprendere la quale al di là dei generici immaginari distopici un ottimo punto di partenza è un libro uscito in traduzione italiana alla fine del 2019: Il capitalismo della sorveglianza. Il futuro dell’umanità nell’era dei nuovi poteri di Shoshana Zuboff (Luiss).
Mercato dei comportamenti futuri
Le origini di quello che Shoshana Zuboff chiama capitalismo della sorveglianza risalgono alle soglie del terzo millennio, quando Google capisce che i dati e i metadati (cioè “dati sui dati”: le informazioni aggiuntive sul come è stata effettuata una ricerca, al di là del contenuto della stessa) generati da ogni ricerca effettuata da un utente, fino a quel momento considerati “scarti” per la parte eccedente rispetto a quella necessaria per il miglioramento del servizio stesso, potevano rappresentare in realtà preziosa materia prima – che l’autrice definisce surplus comportamentale – che si sarebbe potuta trasformare in prodotti predittivi – cioè dati strutturati sul comportamento futuro degli utenti, ricavati da quelli relativi al loro comportamento passato – da rivendere alle aziende inserzioniste, desiderose di poter investire in pubblicità quanto più possibile individualizzata e quindi più remunerativa, in un nuovo e fiorente mercato dei comportamenti futuri. In sostanza, Google ha scoperto che fornire semplicemente un servizio che risponda ai bisogni degli utenti è molto meno remunerativo che vendere previsioni sul loro comportamento, ricavate dai dati raccolti attraverso l’uso del servizio stesso, a chiunque sia interessato. In breve tempo, questo modello di business è diventato lo standard del capitalismo su internet.
Il problema dei due testi
I meccanismi esatti attraverso i quali Google e compagnia si accaparrano e riutilizzano informazioni dettagliate su tutti i nostri comportamenti online – anche quelli che non avvengono direttamente attraverso i prodotti della stessa azienda – non sono intelligibili: il capitalismo della sorveglianza (e questo vale anche per il resto dell’apparato tecno-scientifico), alla faccia della trasparenza, si basa su un’immensa, costitutiva asimmetria di conoscenza, oltre che di potere. L’autrice parla di problema dei due testi: il primo testo è il contenuto informativo della rete, quel che appare sui nostri schermi, rivolto a “noi” e spesso da noi stessi prodotto. La produzione e la fruizione di questo primo testo seminano però continuamente alle proprie spalle materie prime, sotto forma di dati, analizzate e accumulate nel secondo testo, il testo ombra, nascosto alla nostra vista e accessibile solo a uno «stretto clero di specialisti informatici», e che «dice di noi più di quanto noi stessi possiamo sapere».
Intelligenza artificiale
I prodotti predittivi vengono ricavati dai dati grezzi dandoli in pasto all’intelligenza artificiale – «il nuovo mezzo di produzione» –, che, a differenza di quanto accade nell’industria, «dove c’era una tensione tra quantità e qualità», cresce di pari passo con la quantità dei dati a disposizione. Riprendiamo una spiegazione accessibile del processo di apprendimento automatico attraverso il quale le macchine imparano a “leggere” la realtà da Guerra digitale. Il 5G e lo scontro tra Stati Uniti e Cina per il dominio tecnologico di Francesca e Luca Balestrieri (Luiss, 2019): fino all’inizio del nuovo millennio, «i computer sono stati “intelligenti” solo per la loro capacità di applicare un insieme di regole predefinite ed esplorarne le possibilità con una velocità e una potenza di calcolo bruta meccanicamente superiori a quelle della mente umana. […] L’intelligenza artificiale del nuovo millennio ha invece proprio la caratteristica di imparare e di ricavare per proprio conto regole, strutture e soluzioni: è machine learning. In questo caso, il sistema intelligente riceve dall’esterno dati in grandi quantità (più ne riceve e più impara), li usa statisticamente per ricalibrare i propri parametri interni e, su questa base, è capace di generalizzazione, cioè di elaborare predizioni verosimili anche quando s’imbatte in situazioni o casi nuovi. Le tecniche più avanzate di machine learning si basano su sistemi di reti neurali artificiali, che prendono a modello le reti neurali presenti nel cervello umano». L’incremento della quantità di dati a disposizione e della potenza di calcolo ha permesso di «padroneggiare l’aumento di “profondità” (ossia del numero di strati) delle reti neurali: si ha così il deep learning. […] Avere una stratificazione più profonda, in cui ogni strato si specializza in una funzione e prende decisioni che poi reimmette nella rete neurale, permette alla macchina di “imparare” e acquisire “conoscenze” di maggiore complessità. Il riconoscimento delle immagini è un buon caso per rappresentare in modo semplificato il funzionamento del deep learning. Per esempio, nell’istruire una rete neurale artificiale al riconoscimento delle immagini di gatti, i primi strati si specializzano nell’identificare forme geometriche semplici, come le linee rette; strati più profondi riconoscono invece angoli, curve, ombre; strati più profondi ancora individuano orecchie, zampe e via dicendo. Intuitivamente, a una maggiore profondità corrisponde una capacità di addestramento a compiti più complessi. […] Le conquiste tecniche del deep learning hanno permesso un salto qualitativo dell’intelligenza artificiale, rappresentato dal passaggio dall’elaborazione di dati già strutturati, come avveniva nei primi decenni, alla capacità di organizzare e analizzare dati non strutturati, quali ad esempio i testi in linguaggio naturale, la voce umana, le immagini video. Nel 2017, i più efficienti assistenti vocali erano già in grado di comprendere la voce umana con una percentuale di parole fraintese inferiore a quella che si registra mediamente nel dialogo tra due persone; e da allora i progressi sono stati rapidissimi perché quanto più il sistema intelligente ingerisce parole e frasi, tanto più diviene esperto e tanto più si riduce il tasso di errore».
Se si considera il contributo portato al miglioramento dei sistemi di riconoscimento automatico, gesti come postare un selfie su Facebook o fare una “riunione” su Zoom perdono molta della loro “innocenza”: come riporta Shoshana Zuboff, grazie all’enorme quantità di immagini postate dagli utenti, «nel 2018, il team di ricerca di Facebook ha annunciato di aver “colmato il divario” e di essere ormai capace di riconoscere i volti “nella natura” con un’accuratezza del 97,35 per cento, “molto vicina alle performance degli esseri umani”. […] Nel 2018, le macchine stavano imparando a distinguere attività, interessi, umori, sguardi, abbigliamento, camminata, pettinatura, tipo corporeo e postura».
Inoltre, come l’autrice nota a proposito dell’automazione nell’industria – la cosiddetta «industria 4.0» –, «il potere dell’apprendimento delle macchine si sviluppa in modo esponenziale grazie a dispositivi che riescono a imparare dalle esperienze reciproche, cibandosi dell’intelligenza dell’hub e nutrendola a loro volta. In quest’ottica, l’insieme non è semplicemente più grande delle sue parti: le parti non ci sono più. Il complesso è onnipresente, pienamente incarnato in ogni dispositivo incorporato in ogni macchinario». Un esempio è quello dei veicoli a guida autonoma: «alla guida, le persone imparano quasi solo dai propri errori, e di rado dagli errori degli altri. […] Quando un’autovettura autonoma fa un errore, tutti i veicoli simili possono usarlo per imparare. Queste nuove auto “nascono” già con tutte le abilità di chi le ha precedute e dei propri simili. Collettivamente queste auto sono pertanto in grado di imparare più in fretta delle persone».
Sorvegliare e classificare
I dati sui comportamenti e le previsioni ricavate dalla loro analisi non interessano solo agli inserzionisti desiderosi di investire in pubblicità più mirate ed efficaci: per esempio, per banche e finanziarie è ora possibile «stabilire istantaneamente se una persona può accedere a un prestito basandosi sull’estrazione di informazioni dettagliate sul suo smartphone o su altri comportamenti online, compresi messaggi, email, coordinate GPS, post sui social media, profili Facebook, transazioni d’acquisto e pattern di comunicazione». Un’azienda «vende accurati monitoraggi eseguiti sulle credenziali di potenziali impiegati o inquilini a datori di lavoro o padroni di casa. Ad esempio, un potenziale inquilino può ricevere dal proprio potenziale locatore la richiesta di accesso totale al suo profilo sui social media. Il servizio può così “passare al setaccio la nostra attività sul sito”, comprese intere conversazioni e messaggi privati, processare il linguaggio che abbiamo utilizzato e usare altri software analitici. Alla fine ne esce un resoconto che cataloga tutto, dalla nostra personalità al nostro “livello di stress finanziario” […]. Chi viene sottoposto al processo non ha modo di vedere o contestare le informazioni. Come nel caso dei prestiti digitali, per quanto un potenziale inquilino debba formalmente accettare il servizio in modo esplicito, chi ha meno soldi e opzioni si trova intrappolato». Al di là della capacità attuale e futura dell’intelligenza artificiale di ricavare un resoconto effettivamente fedele alla realtà, il punto è la performatività del processo: per determinate categorie di persone potrà essere comunque più difficile trovare una casa in affitto. E, tendenzialmente, non avere affatto un profilo sui social si tradurrà in un motivo di sospetto – o direttamente di esclusione. Per non parlare del non possedere uno smartphone, che già oggi è sempre più spesso un prerequisito non solo per trovare un lavoro (è diventato difficile anche poter fare il cameriere, senza avere WhatsApp), ma anche per accedere a servizi pubblici: tanto per fare un esempio, l’ultimo «bonus vacanze» poteva essere richiesto solo attraverso un’app per Android o iOS. Per bonus e cashback ce ne faremo una ragione, ma la cosa è indicativa.
A caccia di dati nel mondo reale
Compreso il valore del surplus comportamentale, Google ha iniziato a cercare di accaparrarsene attraverso sempre nuovi servizi e colonizzando sempre nuovi territori, in senso sia figurato che letterale. «Gli archivi di surplus comportamentale di Google attualmente comprendono qualunque elemento del mondo digitale»: oltre al motore di ricerca, a Gmail, a Maps ecc., si pensi a YouTube, al browser Chrome e soprattutto ad Android, sistema operativo della maggior parte degli smartphone e dei tablet del mondo (per dire: «Nel novembre del 2017, un’inchiesta di Quartz ha rivelato che dall’inizio dell’anno Android stava raccogliendo informazioni per mezzo di triangolazioni con le antenne più vicine, anche quando la geolocalizzazione era disabilitata, le app non erano in funzionamento, e nel telefono non c’era neanche la scheda SIM […], consentendo all’azienda di tracciare “qualunque individuo con un telefono Android o con delle app Google abbia messo piede in un particolare negozio, e usare queste informazioni per targettizzare la pubblicità e farla vedere a quell’utente”»). A proposito dell’espansione dell’imperativo dell’estrazione dei dati dal mondo virtuale a quello reale, l’autrice fa l’esempio di Google Maps e Street View: «il “copilota” Google suggerisce a un individuo di svoltare a destra o a sinistra su un percorso definito da una conoscenza della persona e del contesto che cresce in continuazione. Le previsioni su dove e perché una persona possa spendere del denaro derivano dall’accesso esclusivo di Google al surplus comportamentale […]. L’analisi del surplus di Google può prevedere la tua intenzione di comprare un costoso abito di lana, e i suoi dati di localizzazione in tempo reale possono attivare il suggerimento online di un venditore o di un inserzionista, abbinato al tuo profilo e inviato nel momento stesso in cui ti trovi tra tweed e cachemire». E «ogni risposta umana a ogni suggerimento commerciale offre più dati che possono portare a prodotti predittivi più efficaci». L’obiettivo è quello, come è stato scritto, di «mettere il più possibile in cortocircuito il processo di riflessione che si situa fra il riconoscimento di un proprio desiderio e la sua realizzazione attraverso il mercato». La colonizzazione della realtà da parte dei capitalisti della sorveglianza passa per gli smartphone e quell’architettura dell’estrazione rappresentata dall’internet delle cose (IoT, Internet of Things: dispositivi indossabili, domotica, veicoli autonomi e non, infrastrutture della smart city: tutto dotato di sensori in grado di raccogliere, analizzare e comunicare quantità inimmaginabili di dati in tempo reale). Questa proliferazione di dispositivi si traduce, come abbiamo visto per Google Maps, sia in nuove fonti di approvvigionamento di dati comportamentali, sia in nuovi terreni per pubblicità mirate, contribuendo così all’espansione del mercato dei prodotti predittivi. Dietro c’è una concorrenza spietata, alla ricerca del monopolio sulle fonti di approvvigionamento di dati e sul mercato dei prodotti predittivi in un dato settore.
Questo passaggio alle economie di scopo (create cioè appositamente per generare nuovo surplus comportamentale e mercato per i prodotti predittivi) avviene in due dimensioni: una è appunto l’estensione delle operazioni di estrazione dal mondo virtuale a quello “reale”; l’altra è la profondità, basata «sull’idea che il surplus comportamentale più predittivo, e pertanto più remunerativo, possa essere scandagliato nelle dinamiche più intime del sé. Queste operazioni di rifornimento mirano alla nostra personalità, ai nostri stati d’animo, alle nostre emozioni, bugie, e ai nostri punti deboli».
Le operazioni attraverso le quali la nostra esperienza viene trasformata in dati sono dette renderizzazione, e gli esempi sono infiniti. Ogni prodotto viene ripensato come possibile miniera di dati e reso smart: ad esempio, la iRobot ha dichiarato l’intenzione di fare affari vendendo le piantine delle case dei clienti ricavate dalla mappatura effettuata dall’aspirapolvere autonomo Roomba mediante telecamere, sensori e software incorporati. Il letto Sleep Number, attraverso sensori che misurano battito cardiaco, respiro e movimenti, attribuisce ogni mattina un punteggio alla qualità del sonno. «L’azienda vi consiglia di collegare la vostra app del sonno al vostro tracker per il fitness e al vostro termostato per vedere che influenza hanno l’attività fisica o la temperatura della camera da letto sul vostro sonno». La competizione si è scatenata particolarmente attorno ai nostri discorsi, dei quali ai capitalisti della sorveglianza interessa sia, ovviamente, il contenuto, sia il fatto che allenano le macchine al riconoscimento vocale, nel sistema che si autoalimenta descritto sopra. Per «imporre la “conversazione” come medium di interazione tra esseri umani e apparato» il mezzo privilegiato sono gli “assistenti personali digitali” come Google Now o Siri, ma si arriva fino alle bambole interattive che catturano tutto quel che dice il bambino nelle conversazioni nelle quali lo coinvolgono. Il “cervello” dell’assistente digitale di Amazon, Alexa, è ormai incorporato in moltissimi «dispositivi per smart home, dai sistemi di illuminazione alle lavastoviglie […]. Nel 2018, Amazon ha firmato dei contratti con alcuni costruttori di case, installando le proprie casse Dot direttamente nei soffitti dell’intera abitazione, oltre a dispositivi Echo, e a serrature, interruttori, sistemi di sicurezza, campanelli e termostati potenziati da Alexa».
Analisi delle emozioni
Dopo la voce, il prossimo passo è la renderizzazione della sfera emotiva. Cinque anni fa la startup Realeyes vinse prima un cospicuo finanziamento e poi un premio da parte della Commissione europea per un progetto il cui scopo era «sviluppare una tecnologia automatica in grado di leggere le emozioni di una persona mentre questa vedeva un contenuto, per stabilire poi come si correlavano all’apprezzamento del contenuto stesso». Questo nuovo promettente settore è chiamato affective computing, «analisi dei sentimenti». Le tecnologie come quelle sviluppate da Realeyes «utilizzano un software specializzato per scandagliare volti, gesti, corpi e menti, catturati da “biometriche” e sensori “profondi”, spesso combinati con videocamere incredibilmente piccole e “discrete”. Questo complesso di intelligenza delle macchine viene addestrato a isolare, catturare e renderizzare i comportamenti più sfumati e intimi: da un inconsapevole battito di ciglia a una mascella che si serra per la sorpresa in una frazione di secondo. La combinazione di sensori e software può riconoscere e identificare i volti; stimare età, etnia e genere; analizzare la direzione di uno sguardo e un batter d’occhi; tracciare distinti punti facciali per interpretare “micro-espressioni”, movimenti dell’occhio, emozioni, umori, stress, bugie, noia, confusione, intenzioni e molto altro: tutto alla velocità della vita». Esistono società che offrono le proprie «analisi delle emozioni» come servizio: «Registrate le persone mentre esprimono le loro emozioni e poi inviate a noi i video o le immagini per ottenere delle efficaci misurazioni emotive». E questo emotion scanning potrebbe diventare onnipresente, grazie a chip impercettibili inseriti letteralmente in qualunque cosa (secondo un dirigente del colosso dei processori per smartphone Qualcomm, «una bambola può rendersi conto di essere guardata da un bambino»). A proposito di computazione ubiqua, oggetti smart e ambienti discretamente disseminati di sensori, la smart skin o e-skin, “pelle elettronica”, dalle sembianze di un semplice adesivo e che non ha bisogno di batterie grazie alla capacità di ricevere energia «dalle onde radio o da altre forme energetiche», può essere applicata ovunque, per «monitorare, avvertire e interagire con il mondo in modo perpetuo». Praticamente, ci troviamo di fronte alla trasformazione dell’intera realtà in una piattaforma di monitoraggio continuo.
Il modo più sicuro per prevedere un comportamento è determinarlo
Il passaggio successivo dettato dall’imperativo della previsione è la creazione di economie d’azione. I capitalisti della sorveglianza si rendono conto che per approssimarsi il più possibile alla certezza – e quindi al massimo della remuneratività – nella previsione di un comportamento, il modo migliore è intervenire alla fonte sul comportamento stesso, determinandolo, tramite «architetture del mondo reale» che devono «essere in grado sia di sapere, sia di fare. L’estrazione non basta più, ma dev’essere abbinata all’esecuzione. L’architettura dell’estrazione viene affiancata dalla nuova architettura dell’esecuzione attraverso la quale obiettivi economici nascosti vengono imposti su una vasta gamma di vari comportamenti». Le tecniche di modifica dei comportamenti non sono certo una novità assoluta, ma ora la tecnologia permette di renderle automatizzate, individualizzate e in tempo reale. A tal proposito, Shoshana Zuboff parla di potere strumentalizzante. La nuova frontiera in questo senso sono giochi e altre applicazioni basate sulla realtà aumentata. L’esempio è Pokémon Go, il gioco che ha spopolato alcuni anni fa e che consisteva nel dare la caccia con lo smartphone, attraverso GPS e videocamere, alle creature virtuali che comparivano sullo schermo quando si raggiungeva il luogo reale – strade, parchi, esercizi commerciali – nel quale erano posizionate. I reali clienti di un gioco come questo sono i soggetti disposti a pagare, ad esempio, perché i Pokémon vengano posizionati all’interno o nei pressi delle loro attività. Inoltre, «come gran parte delle app che utilizzano il GPS del vostro smartphone, Pokémon Go è in grado di dire molte cose di voi basandosi sui vostri movimenti di gioco: dove andate, quando e come, quanto ci restate, e chi altro era presente»: questo permette di migliorare progressivamente la capacità di guidare i giocatori – nel mondo reale e in tempo reale – verso guadagni sicuri per sé e i propri clienti. Pokémon Go è anche un esempio di «un approccio all’ingegneria dei comportamenti» definito gamification: «i ricercatori in genere prevedono che i giochi verranno usati sempre più come metodologia principale per il cambiamento del comportamento individuale. In pratica, il potere dei giochi di cambiare i comportamenti è stato strumentalizzato senza ritegno, con la diffusione della gamification in migliaia di situazioni nelle quali un’azienda non vuole fare altro che regolare, dirigere e condizionare il comportamento dei propri clienti o impiegati rivolgendolo verso i propri obiettivi. In genere questo significa importare alcune componenti, come i punti bonus e l’avanzamento di livello, per determinare comportamenti che tornano comodi agli interessi dell’azienda, con programmi che premiano la fedeltà dei clienti o la competizione per le vendite tra gli impiegati». Il tipo di azioni dirette a determinare i nostri comportamenti vanno da quelle impercettibili e già ampiamente utilizzate come inserire surrettiziamente un determinato contenuto nel nostro feed di Facebook a quelle decisamente più intrusive ma già disponibili e in via di sperimentazione come non far accendere il motore dell’auto se non abbiamo pagato l’assicurazione – o far salire in tempo reale il premio se andiamo troppo veloce o, per esempio, parcheggiamo in una zona considerata malfamata… «Le assicurazioni mediche sono un altro target: “Gli accelerometri indossabili” possono “migliorare la tracciabilità dell’eventuale rispetto” dei regimi di esercizio prescritti, e i “sensori digeribili” possono verificare se le prescrizioni di medico e dietologo vengono ascoltate». E qui tocca aprire un inciso: uno degli sviluppi tecnologici il riferimento ai quali suscita solitamente più ilarità perché associato alle tesi di deliranti complottisti è quello dei microchip sottopelle. Ebbene, l’impianto di chip sottocutanei – ovviamente con motivazioni sanitarie: consentono ad esempio istantaneamente l’identificazione certa e l’accesso alla storia clinica di un soggetto in stato di incoscienza – è una realtà da parecchi anni in diversi paesi. È così delirante immaginare che in un futuro non troppo lontano possano essere resi obbligatori (magari de facto, come il vaccino per il covid) a fini di sorveglianza, dopo averli sdoganati puntando su sicurezza e comodità? Tornando agli automatismi come la macchina che non si accende se non abbiamo pagato il bollo, Shoshana Zuboff ne parla come di non-contratti (altri parlano di smart contracts): «Il non-contratto non è uno spazio per relazioni contrattuali ma un’esecuzione unilaterale che rende superflue tali relazioni», prevenendo qualsiasi azione alternativa.
Il passo successivo va dalla renderizzazione e dall’automazione dell’individuo a quelle dei gruppi sociali. Cellulari e dispositivi indossabili possono essere utilizzati «per scoprire regole e strutture presenti nel comportamento di individui e organizzazioni»: in un esperimento del MIT, i ricercatori sono riusciti a «definire con regolarità gli schemi di posizionamento spaziale e temporale, le attività e i pattern nella comunicazione, arrivando a predire con un’accuratezza del 90 per cento dove si sarebbe trovata una persona e che cosa avrebbe fatto nel giro di un’ora, oltre a elaborare previsioni su colleghi, amici e persone care dei singoli individui». Questo ci porta al tema dell’impatto del cluster tecnologico formato da internet delle cose, intelligenza artificiale, automazione intelligente, “supercomputer” e rete 5G sul mondo del lavoro, che tende ad essere considerato solo dal punto di vista della disoccupazione tecnologica, trascurando le possibilità offerte al capitale da queste innovazioni in termini di controllo e intensificazione dello sfruttamento.
Liberi dal lavoro?
Molti dei lavori più diffusi sono destinati in breve tempo a poter essere svolti dalle macchine in totale autonomia o, inizialmente, con l’aiuto di pochi supervisori umani. Si pensi agli autotrasportatori: come osserva Adam Greenfield in Tecnologie radicali. Il progetto della vita quotidiana (Einaudi, 2017), «la tendenza principale della comunicazione mediatica è dominata dalle autovetture driverless, come quelle che stanno sviluppando Uber e Google. Ma il regime di performance, spartano e pensato per l’autostrada, del trasporto su gomma a lunga distanza è molto più adatto all’automazione di quanto non sia la guida dell’automobile nel traffico e in un ambiente urbano e suburbano». L’apprendimento automatico delle macchine e il controllo tecnologico arrivano però progressivamente a minacciare anche professioni che si sarebbero credute al riparo: il “supercomputer” di IBM Watson promette diagnosi e decisioni sulle terapie da seguire assai più affidabili di quelle dei medici umani, grazie al fatto che l’intelligenza artificiale può “leggere” in pochi secondi tutta la letteratura scientifica esistente e considerare in tempo reale tutti i dati a disposizione su una patologia (ovviamente, è ancor più efficace dei medici in carne ed ossa anche nell’evitare di considerare nocività e cause sociali delle patologie, riducendo definitivamente la salute a una questione di parametri numerici…). Secondo Greenfield, i progressi dell’intelligenza artificiale ci fanno «intravedere il tempo in cui quasi ogni tipo di capacità umana potrà essere scavata per trarne le regole implicite, e ridefinita come un esercizio di riconoscimento e riproduzione di modelli, anche di quelli apparentemente più dipendenti dal sentimento e dall’improvvisazione». Intanto, in attesa che le macchine sostituiscano anche loro, i collaboratori di alcuni studi legali si vedono calcolare la propria produttività attraverso software gestionali che tengono traccia del tempo impiegato per ogni loro attività quotidiana, dalla redazione di una lettera a una telefonata o un confronto con un collega. Più che la “liberazione dal lavoro” vagheggiata da alcuni, la prospettiva sembra essere, almeno nel medio periodo, quella della sua polarizzazione: la scomparsa di molti lavori “intermedi” e l’allargamento della forbice fra quello che Shoshana Zuboff chiama stretto clero di specialisti informatici e chi sarà costretto a lavorare sotto l’algoritmo per il capitalismo delle piattaforme – o a morire estraendo i metalli rari necessari alla produzione del tecnomondo.
L’aspetto che tende a rimanere più in ombra ma che ci sembra altrettanto importante è proprio il significato che assume il progresso tecnologico per coloro che, almeno per il momento, il lavoro lo conserveranno (o ne troveranno uno nella cosiddetta gig economy, l’economia dei “lavoretti” per conto delle piattaforme come Deliveroo, Glovo o Uber): «a questa ridotta forza lavoro verrà chiesto di fare di più, a un ritmo più sostenuto e per un salario più basso». L’esempio classico sono i centri logistici di Amazon – il cui giro d’affari si è ulteriormente impennato proprio grazie alla pandemia, e infatti in Italia ne stanno sorgendo di nuovi: perché i prodotti possano essere consegnati agli acquirenti nei tempi sempre più ridotti che vengono loro promessi, i lavoratori rimasti a convivere con i robot devono competere per il rinnovo del contratto sulla base di obiettivi di giornata sempre più insostenibili, mentre qualsiasi errore o interruzione – ad esempio per andare in bagno – è sempre tracciabile e contribuisce ad abbassare il proprio rate. Altro settore per il quale la pandemia ha rappresentato un affare d’oro è quello delle piattaforme di delivery per le quali lavorano i rider (Deliveroo, Glovo, JustEat ecc.). Il fenomeno è noto: presentato come “lavoretto” grazie al quale gli studenti avrebbero potuto arrotondare facendo, in più, attività fisica all’aria aperta, si tratta in realtà dell’unica fonte di sostentamento di lavoratori, in molti casi immigrati, che non godono di nessuna di quelle minime garanzie delle quali ancora beneficiano i lavoratori dipendenti “classici”, e soprattutto che lavorano a cottimo monitorati e comandati attraverso lo smartphone da un algoritmo – i criteri di funzionamento del quale possono solo immaginare – che decide, in base alle loro performance, alle recensioni – veritiere o no – dei clienti o magari al fatto che qualcuno osi rivendicare migliori condizioni, se, quando e quanto farli lavorare. Sempre secondo Greenfield, i lavoratori che manterranno il posto potrebbero ritrovarsi «soggetti ad avere i turni organizzati da algoritmi di organizzazione, senza o quasi preavviso, per periodi potenzialmente incompatibili con il bisogno di sonno o riposo, con la vita familiare o altri impegni». L’autore cita un ex segretario del Lavoro degli Stati Uniti che prospetta un’economia nella quale «tutti lavorano a cottimo a tutte le ore più strane e nessuno sa quando arriverà il prossimo lavoro e quanto verrà pagato». Intanto, «il posto di lavoro diventa l’arena di ogni sorta di monitoraggio e taratura delle performance: alla catena di distribuzione statunitense Target, ad esempio, un sistema automatico classifica ogni operazione alle casse come “verde”, “gialla” o “rossa”, a seconda della velocità e della precisione con cui viene eseguita; le valutazioni sono poi utilizzate per determinare il compenso del cassiere. […] Ai venditori di ogni negozio della catena The Container Store a partire da giugno 2016 è stato chiesto di portare i “dispositivi aziendali indossabili” prodotti da una startup di nome Theatro. Questi dispositivi tengono traccia della posizione degli impiegati e forniscono un riscontro in tempo reale delle loro interazioni con i clienti. L’azienda usa la serie di dati che ne deriva per “riconoscere i migliori” (e, di conseguenza, i più scarsi) e quindi pianificare programmi e distribuire mansioni». Un’altra startup offre tesserini «“dotati di due microfoni, un sensore di localizzazione e un accelerometro” e capaci di registrare “tono di voce, postura, linguaggio del corpo, chi parla a chi e per quanto tempo”. […] Per offrire ai capi una panoramica completa del comportamento dei dipendenti, i dispositivi indossabili lavorano in sincronia con i sistemi della postazione di lavoro. I lavoratori della Kentucky Fried Chicken, di Wendy’s e della catena di drugstore Rite Aid quando sono sul punto di fare una vendita si collegano biometricamente alle loro postazioni attraverso [un sistema] capace di prevenire “arrivi in ritardo, dipendenti che timbrano per i colleghi, chiacchiere sul lavoro, pause prolungate e uscite in anticipo, errori d’inventario, sconti o resi non autorizzati, carte regalo fraudolente”». Come abbiamo visto, però, il capitalismo della sorveglianza non si ferma a questo livello di controllo: «Con la crescita della capacità di individuare e caratterizzare gli stati emotivi, […] si sono aggiunte le preoccupazioni per la performance emotiva del lavoratore. L’azienda giapponese Keikyu, ad esempio, nel 2009 ha iniziato a misurare la qualità dei sorrisi dei suoi dipendenti a contatto con il pubblico, passando allo scanner i loro “movimenti oculari, le curve delle labbra e le rughe di espressione” […]. Per quanto questa pratica possa sembrare intrusiva, almeno il sorriso resta sotto il controllo consapevole del dipendente, il che non si può dire per tutte le misurazioni di “postura corporale, espressione facciale, fisiologia, semantica [e] quando e con chi una persona parla” che raccomanda la società di consulenza gestionale Accenture per assicurarsi che i dipendenti stiano “mostrando efficaci comportamenti sociali”». Giustamente l’autore nota che «la cosa saliente non è tanto che questi strumenti funzionino davvero come vengono pubblicizzati, ma che gli utenti siano indotti a credere che lo facciano». In Italia è stato il Jobs Act introdotto dal centrosinistra a sdoganare – oltre alla licenziabilità anche dei lavoratori assunti a tempo indeterminato – il controllo a distanza, stabilendo che non sarebbe più stato necessario chiedere alcun permesso per dotare i lavoratori di strumenti (smartphone aziendali ecc.) tramite i quali sarebbe stato possibile monitorare la loro efficienza. È facile immaginare quale livello di controllo e sfruttamento sarà possibile, con l’affinamento e la diffusione dell’intelligenza artificiale, nel caso dello smart working: software in grado di comprendere e segnalare in tempo reale se il lavoratore si trova effettivamente davanti al computer, il suo livello di produttività ecc. – e in prospettiva anche parametri come il suo livello di attenzione –, in un lavoro organizzato sulla base degli obiettivi e non di un orario, portandolo a invadere sempre più tempi e spazi, e svolto in una condizione di isolamento anche fisico dagli altri lavoratori, rendendo ancor più difficile il confronto e l’organizzazione.
Turchi meccanici
Quelle appena descritte sono solo le tendenze più facilmente prevedibili del controllo tecnologico sul lavoro: sempre secondo Greenfield, «abbiamo a malapena le parole per descrivere cosa succede quando un algoritmo scompone il lavoro in mansioni abbastanza semplici da non richiedere nessuna particolare competenza – praticamente alla portata di qualsiasi persona – e le esternalizza a una rete globale di precari disposti a lavorare per un salario molto basso». Un esempio c’è, rappresenta una delle materialità nascoste della digitalizzazione e ci riporta alla solita Amazon. Si tratta del servizio Mechanical Turk, creato nel 2005. Il nome si richiama al “turco meccanico”, un giocatore di scacchi “automatico” che fece scalpore girando l’Europa fra XVIII e XIX secolo, all’interno del quale si nascondeva in realtà un uomo in carne ed ossa. Simone Pieranni, in Red mirror. Il nostro futuro si scrive in Cina (Laterza, 2020), descrive così il servizio: «Naturalmente si tratta di lavori alienanti e pagati pochissimo. I turchi meccanici di Amazon si occupano di riconoscere immagini, trascrivere audio, migliorare pronuncia e dizione delle macchine. Oggi, nel mondo, sono almeno 500mila i lavoratori impiegati in questo genere di servizi. Ma non solo». Una lavoratrice racconta che viene richiesto anche di rispondere a «infinite inchieste sul consumo di bevande energetiche, questionari su come si passa il proprio tempo libero, […] se si pensa che un determinato prodotto sia sufficientemente pubblicizzato. I dati sono la nuova grande ricchezza, il vero prodotto, il valore da estrarre, il nuovo oro da conquistare. I gruppi di ricerca scientifici sono un altro capitolo di questa storia. Per ottenere velocemente dati, si affidano ad Amazon e così contribuiscono a un nuovo tipo di sfruttamento». «I turchi meccanici sono per lo più indiani e statunitensi e – attenzione – la “paga” non è per tutti in denaro: alcuni vengono pagati in buoni acquisti, su Amazon ovviamente». Un lavoro simile a quello svolto in Cina dai cosiddetti “etichettatori”: «Il fantasmagorico piano cinese che prevede di aumentare investimenti e risultati del settore dell’Intelligenza artificiale beneficia, in realtà, di un lavoro piuttosto tradizionale, “in linea”. Perché algoritmi e macchine “ragionino” ed elaborino informazioni è necessario che queste arrivino in fretta, che siano tante, e che vengano catalogate nella maniera più dettagliata e precisa possibile. Tutte le immagini, i video, gli audio devono essere “taggati”, cioè associati a un elemento, a caratteristiche, ad altri dati. I tag sono, in altre parole, dati inseriti da umani che consentono di elaborare, in tempi sempre più rapidi, altri dati. […] Lavoratori che nel corso di una giornata visualizzano migliaia di immagini, etichettando qualsiasi cosa: guardano una foto su uno schermo e appongono etichette. Su qualsiasi cosa: il volto di una persona, una strada, una lunga fila di macchine, panorami e luoghi, animali». Questo per un euro all’ora. I clienti «vanno dalle università statunitensi come Berkeley, ai progetti di veicoli senza guida della Silicon Valley per arrivare ai leader cinesi di Intelligenza artificiale».
Spirali di dipendenza e isolamento
I servizi – gratuiti! – offerti da Google, Facebook e compagnia sfruttano le vulnerabilità prodotte da una società sempre più ostile per gli individui offrendo loro false soluzioni – illusione di socialità, accesso alle informazioni, comodità, risparmio di tempo – che aggravano ulteriormente il loro isolamento, e inducono una dipendenza crescente. Come osserva Shoshana Zuboff, «dopo il primo morso, la mela si rivela irresistibile. Con la diffusione del capitalismo della sorveglianza nel web, i mezzi di partecipazione sociale finiscono per combaciare con i mezzi di modifica dei comportamenti». Alla dipendenza si associano le altre conseguenze psicologiche della vita nell’alveare, ossia nella società prefigurata dal capitalismo della sorveglianza: «incapacità di disconnettersi, noia, confusione, angoscia e isolamento». Nel corso di un esperimento, «l’improvvisa disconnessione degli studenti ha prodotto bisogni e stati di depressione e ansia tipici delle dipendenze diagnosticate clinicamente. Stando ai risultati della ricerca, in ogni Paese la maggioranza dei soggetti ha ammesso di non poter sopportare un giorno di disconnessione. La loro angoscia deriva dal patto faustiano che conosciamo fin troppo bene, e dal rendersi conto che quasi tutte le loro esistenze logistiche, comunicative e informative dipendevano da dispositivi connessi in rete […]. Per gli studenti è stato inoltre impossibile immaginare forme di partecipazione sociale senza i social media». L’idea che sta dietro Facebook e gli altri social è «quella di indirizzarci “una piccola scarica di dopamina di tanto in tanto”, ovvero un “rinforzo variabile”, in forma di like e commenti, con lo scopo di tenere gli utenti incollati all’alveare, all’inseguimento di quelle scariche, “lasciando dietro di loro una scia di materie prime”». Mano a mano «il guanto si stringe con i loop di feedback […] che danno la precedenza ai post delle persone con le quali avete già interagito, ai post che hanno già coinvolto molte persone e ai post simili a quelli con i quali avete già interagito». «Questa tecnologia che calza come un guanto non è stata inventata da Facebook, ma è stata anticipata, testata e perfezionata con enorme successo dall’industria del gioco, un altro contesto nel quale la dipendenza viene riconosciuta formalmente come una fonte inesauribile di profitto». La conseguenza è la riduzione della socialità (dietro l’illusione del suo ampliamento) a «un registro di “amici” che non sono veri amici e di “like” che sanciscono costantemente il valore di una persona sul mercato sociale, alimentando le ansie della giovinezza e anticipando l’ipnotica disciplina sociale dell’alveare». Come tutte le tecnologie, i social ci sottraggono le nostre capacità umane, in questo caso la capacità di relazione, sostituendole con un surrogato illusorio. Se anche la televisione sottraeva spazio ai rapporti reali, i social sanno nascondere meglio l’isolamento che alimentano, consentendo «una presentazione attiva del sé, caratterizzata da un “profilo gonfiato” nel quale dati personali, foto e aggiornamenti sono pensati per apparire migliori, e conquistare popolarità, autostima e felicità. I profili gonfiati spingono gli altri a valutarsi in modo peggiore, e a gonfiare a loro volta i propri profili». Ben pochi sono al riparo da questo gorgo di virtualità: capita di dover vedere “antagonisti” mettere in scena – di spettacolo si tratta – simulacri di “azione” nel mondo reale al solo scopo di postarli poi sui social (perché lì sì che “girano”), in un trionfo di inconsistenza, di abdicazione alla realtà.
Una civiltà in cui un comportamento imprevedibile equivale a un guadagno perso
Shoshana Zuboff descrive così il significato più generale dei fenomeni di cui sopra: «Gli interessi dei capitalisti della sorveglianza sono passati dall’uso di processi automatizzati per conoscere il nostro comportamento all’uso delle macchine per dare forma al nostro comportamento al fine di ricavarne quanti più vantaggi possibili. In altre parole, la traiettoria dell’ultimo decennio e mezzo ci ha portati da flussi automatizzati di informazioni su di noi alla nostra automatizzazione». Rispetto al capitalismo industriale che ha caratterizzato gli ultimi due secoli con la sua corsa alla conquista e al dominio della natura per piegarla ai propri interessi, producendo il disastro che è sotto gli occhi di tutti coloro che non si rifiutano di vedere, «il capitalismo della sorveglianza ha puntato il mirino sulla natura umana». Nella civiltà industriale «la cultura, la psicologia e la socialità vennero determinate dalla divisione del lavoro. Il passaggio dall’artigianato allo stipendio fisso creò nuove popolazioni di impiegati e consumatori, uomini e donne interamente dipendenti da mezzi di produzione detenuti e gestiti da aziende private [o dallo stato, poco cambia]. È stato il punto di snodo della società di massa, della sua autorità gerarchica, e delle sue forme di potere pubblico e privato centralizzate e burocratizzate, mentre su tutto aleggiavano gli spettri di conformismo, sottomissione e standardizzazione degli esseri umani. Le vite venivano definite da istituzioni che rispecchiavano l’organizzazione industriale, scuole, ospedali, e sotto certi aspetti anche la vita domestica e la famiglia […]. In un’epoca nella quale il capitalismo della sorveglianza è emerso come forma dominante di capitalismo dell’informazione, dobbiamo chiederci: che tipo di civiltà ci preannuncia?». Una civiltà in cui «il futuro collassa in un presente infinito fatto di mero comportamento, nel quale non ci possono essere soggetti o progetti ma solo oggetti», e l’intera realtà è un’infrastruttura progettata per privarci della possibilità di decidere. Come osserva Adam Greenfield, i suoi sostenitori affermano che il mondo edificato dalle tecno-scienze trascende «la conoscenza imperfetta, l’esperienza particolare e la variabile formazione del singolo […], per sostituirli con una fredda e obiettiva intelligenza collettiva derivata da milioni di dati. Ma cos’è questa intelligenza se non il distillato del modo che nel passato abbiamo adottato per dare un ordine alle nostre società?».
La Cina è vicina
Per capire verso dove stiamo andando, un modello, proposto anche dalla stessa Zuboff, può essere quello della Cina, descritto più approfonditamente da Simone Pieranni, con il suo sistema dei crediti sociali.
«Il Scs è un sistema di monitoraggio e controllo costante, 24 ore su 24, del comportamento di cittadini, aziende ed enti, messo in atto grazie all’applicazione su larga scala di tutte le nuove tecnologie sviluppate dall’espansione del comparto tecnologico cinese: videocamere intelligenti, riconoscimenti facciali, algoritmi, intelligenza artificiale, sensori delle smart city, […] unitamente alla velocità di calcolo garantita dal 5G. L’analisi e la valutazione dei comportamenti dei cittadini, elaborate in base ai dati raccolti dai vari strumenti tecnologici, determinano i diversi gradi di affidabilità di ciascuna persona. Sulla base dei “punteggi” che risultano, vengono anche stabiliti dei sistemi di premi e punizioni di azioni individuali come ad esempio il mancato pagamento di una multa o di un debito: immaginiamoci un immenso database dove tutti i nostri comportamenti e i loro “output” sanzionatori o premianti vengono riposti dando vita a dei “profili”; sulla base di questi profili, una persona potrà essere considerata o meno un cittadino in grado di godere dei servizi offerti dallo Stato (o dalle aziende)». Al momento, non si tratta ancora di un unico sistema centralizzato, ma di vari sistemi sviluppati da istituzioni e aziende, come Ant Financial di Alibaba (il colosso dell’e-commerce cinese) con “Sesame Credit”, che «produce una valutazione “olistica” di un “soggetto”, con un sistema algoritmico di apprendimento che va ben oltre il corretto pagamento di prestiti e bollette. Gli algoritmi valutano e classificano gli acquisti (videogame anziché libri per bambini), livello d’istruzione, quantità e “qualità” degli amici». Questi sistemi, spesso promossi proprio nel nome della trasparenza, sono in realtà tutt’altro che trasparenti: i dati di cui si appropriano e il modo in cui li valutano «rimane fuori dalla nostra portata, e gli utenti possono solo ipotizzare come migliorare i propri punteggi, ad esempio liberandosi di amici con punteggi bassi». «All’inizio il tuo punteggio cala. Poi i tuoi amici vengono a sapere che sei sulla lista nera, e per paura che anche i loro punteggi possano risentirne, senza far troppo rumore rompono i ponti con te. L’algoritmo se ne accorge, e il tuo punteggio scende ancora di più». Secondo chi lo promuove, il sistema «farà in modo che le persone cattive non abbiano socialmente alcun posto dove andare, mentre quelle buone potranno essere libere di muoversi senza alcun ostacolo». Ovviamente, il concetto di “buono” di cui si parla è del tutto ricalcato su quello di legale, ma non solo: i comportamenti che vengono puniti non sono solo quelli che costituiscono una violazione di una legge o di un regolamento, ma anche quelli semplicemente contrari a una “morale sociale” implicita e data per scontata, un po’ come per il decoro nelle nostre città.
Questo ci riporta verso territori più familiari: agli ingenui ai quali sembrerà che sistemi del genere possano risultare proponibili solo in un regime illiberale come quello cinese, converrà infatti ricordare, come esempio di misura indicativa di una tendenza, la “carta a punti” introdotta con il 2020 dall’Istituto Trentino per l’Edilizia Abitativa: ogni inquilino ha a disposizione 30 punti che possono essere via via decurtati in caso di violazione del regolamento, fino all’azzeramento, che comporta la revoca dell’assegnazione dell’alloggio. Tanto per fare un esempio, la «mancata osservanza di norme di pubblico decoro» comporta la decurtazione di 10 punti. Perché meccanismi simili vengano introdotti per chiunque beneficia delle poche misure sociali rimaste, come il reddito di cittadinanza (e anche per l’eventuale «reddito universale» vagheggiato dagli entusiasti che attendono che la tecnologia li liberi dal lavoro), è solo questione di tempo. Nel frattempo, si parla di “passaporto sanitario” (cioè vaccinale) per poter viaggiare e per accedere a cinema, teatri, eventi ecc. Tecnologie come intelligenza artificiale, internet delle cose e 5G non fanno altro che rendere possibile un controllo sul rispetto di queste misure automatizzato e in tempo reale.
5G
Il cosiddetto 5G è la quinta generazione della tecnologia di rete mobile, e sfrutterà tre diverse porzioni di spettro radio: 700 megahertz, 3.700 megahertz e 26 gigahertz. Frequenze che lo stato italiano ha lottizzato e assegnato, per alcuni miliardi di euro, ai principali operatori. Nell’ultimo caso (26 gigahertz) si tratta di onde millimetriche, in grado di trasportare molti più dati a velocità molto superiori, ma con minore portata in termini di distanza: per questo si renderà necessaria una densità molto superiore di ripetitori posti a brevissima distanza fra loro. Questa è la caratteristica che comporterà un’esposizione senza precedenti sia per tipo di onde che per quantità di ripetitori e dispositivi connessi, con, secondo più di qualcuno, gravi conseguenze sulla salute degli esseri umani e delle altre specie. Noi non affronteremo qui il tema degli effetti dell’inquinamento elettromagnetico perché non ci sentiamo di avere le conoscenze per farlo con cognizione di causa; ci limitiamo a considerare che chi, nelle stesse nostre condizioni, considera saggio abbandonarsi con fiducia nelle mani della scienza, degli esperti e delle autorità di regolazione, evidentemente non ha saputo trarre alcun insegnamento dalla storia dell’ultimo secolo, che dimostra come di fronte al profitto il criterio fatto proprio dal capitale e dallo stato che lo difende non sia certo il principio di precauzione (per dire, si sta già premendo perché vengano innalzati i limiti alle emissioni elettromagnetiche previsti dalla legge italiana, e per aggirare intralci come le eventuali opposizioni dei comuni). In ogni caso, ciò che la rete 5G, insieme alle altre tecnologie che serve ad abilitare, rende possibile in termini di controllo dovrebbe bastare e avanzare per assumere l’opposizione con ogni mezzo alla sua implementazione come una priorità. Con la sua bassissima latenza (cioè il ritardo nella trasmissione e ricezione dell’informazione), il 5G è indispensabile per il funzionamento di sistemi come veicoli a guida autonoma, fabbriche interamente robotizzate, smart city. Aumentano le connessioni che possono essere gestite in contemporanea, e «il vantaggio delle reti 5G sta anche nella loro flessibilità: l’architettura del 5G è governata da algoritmi che consentono a servizi diversi di utilizzarne la capacità trasmissiva adattandola dinamicamente alle esigenze dei servizi stessi».
Attorno al 5G e al controllo della filiera produttiva delle apparecchiature che compongono questa infrastruttura – «una filiera industriale molto articolata, che presenta una pluralità di nodi tecnologici sensibili» – si è già scatenata la competizione fra le potenze mondiali, dato che «controllare questi nodi significa avere il potere di condizionare, rallentare o perfino bloccare la produzione di un paese rivale, colpendolo non solo nello sviluppo delle telecomunicazioni ma in tutte le industrie che da queste dipendono, dai servizi per le smart city alla manifattura intelligente agli armamenti», oltre a costituire evidentemente una minaccia per la sicurezza informatica degli avversari.
Polizia automatica

Abbiamo già parlato dei prevedibili sviluppi in termini di controllo nei luoghi di lavoro. Gli altri ambiti nei quali si annunciano ulteriori salti di qualità da questo punto di vista sono quelli che riguardano chi agisce contro o al di fuori dell’ordine sociale: dalla repressione “politica” in senso stretto a quella contro i comportamenti illegali messi in atto dai proletari per motivi di sopravvivenza o per ritagliarsi qualche spazio di libertà (anche il semplice esistere, nel caso di chi non ha il pezzo di carta giusto in tasca). Se già oggi l’impatto in questo senso dell’introduzione di tecnologie come videosorveglianza, analisi del DNA ecc. è significativo almeno quanto i progressivi inasprimenti legislativi, pensiamo a cosa può voler dire l’applicazione non solo alla quantità vertiginosamente crescente di telecamere che appestano le città, ma anche agli oggetti più apparentemente “innocenti”, di un’intelligenza artificiale in grado non solo di registrare, ma di comprendere quel che si fa o si dice nelle sue vicinanze, riconoscere chi lo sta facendo o dicendo e la sua “storia” personale, capire se il contenuto delle azioni o del discorso può essere significativo ed eventualmente segnalarlo e trasmetterlo a chi di dovere, tutto in tempo reale e senza bisogno di operatori umani (tanto per fare un esempio terra terra che può toccare molti, pensiamo a cosa può voler dire cercare di portar via qualcosa da un supermercato in un contesto in cui le telecamere, anziché limitarsi a registrare immagini che devono essere visionate da un operatore che deve dedicare a questo del tempo, sono in grado di accorgersi da sole che qualcuno si sta intascando qualcosa – e magari pure di che personaggio si tratta – e di segnalare il fatto al capetto di turno… questa tecnologia esiste già, deve solo essere affinata e implementata). O pensiamo a cosa può voler dire un drone in grado di “pedinare” un soggetto in maniera del tutto automatizzata e senza che questi possa percepire la sua presenza… Intanto, in Italia la polizia utilizza da un paio d’anni un Sistema Automatico di Riconoscimento Immagini (Sari), che consente di comparare automaticamente un’immagine con diversi milioni di fotografie di soggetti schedati raccolte in una banca dati, segnalando eventuali corrispondenze. Un’altra versione dello stesso software, a quanto riportano i media al momento in fase di perfezionamento, confronterà in tempo reale con un database più ristretto i volti presenti nei flussi video provenienti dalle telecamere di sorveglianza in occasione di eventi pubblici.
Spesso si sente parlare dei salti tecnologici come quello che stiamo vivendo come di rivoluzioni. Ben più appropriato sarebbe considerarli come controrivoluzioni preventive.
Green New Deal
Cosa significhi Green New Deal nei piani del capitale e dei suoi tirapiedi politici è ben esemplificato dal Recovery Plan italiano: alta velocità ferroviaria e rete 5G, pagate con soldi pubblici a debito con la scusa della necessità della ripresa, al costo di nuovi sacrifici futuri. Alla catastrofe ecologica che essa stessa ha generato, la civiltà tecno-scientifica pretende di riparare non certo cambiando direzione ma anzi accelerando, con l’introduzione di sempre nuove tecnologie, più green perché più efficienti, e con in più la spudoratezza di presentare il tutto come transizione ecologica. Dietro la retorica dell’immateriale si cela però la materialità degli effetti sulle condizioni di vita di milioni di proletari – effetti che come vedremo continuano a muoversi lungo le linee del colore della divisione internazionale del lavoro di derivazione coloniale – e di nuove devastazioni ambientali (del resto, le tecnologie dell’informazione sono già state la condizione, tra l’altro, per la globalizzazione finanziaria e le delocalizzazioni produttive). La realtà materiale dietro l’oggetto simbolo e il primo veicolo della digitalizzazione della vita, lo smartphone, è così descritta da Adam Greenfield: «Indipendentemente dal fatto che sia stato progettato nei laboratori di Cupertino, a Seul, o altrove, molto probabilmente il telefono che abbiamo in mano è stato assemblato e preparato per la spedizione e la vendita negli impianti situati a poche decine di miglia dalla città di Shenzhen, nell’agglomerato urbano che si è sviluppato attorno al delta del Fiume delle Perle da quando il governo cinese ha inaugurato la Zona economica speciale nell’agosto del 1980. In queste fabbriche le condizioni di lavoro sono a dir poco inquietanti. Gli orari sono estenuanti, il processo di lavoro – tanto ripetitivo da istupidire – è causa di un enorme numero di infortuni e spesso comporta l’esposizione a prodotti chimici tossici. I salari sono bassi e il tasso di suicidi fra i lavoratori terribilmente alto. Il basso costo del lavoro in Cina, unitamente alla relativamente scarsa capacità dei lavoratori di contestare queste condizioni, è fondamentale per poter assemblare i componenti richiesti da ogni modello e ricavare un congruo margine di profitto mantenendo un prezzo accettabile sul mercato. Se i salari cinesi dovessero cominciare ad avvicinarsi agli standard occidentali, se la manodopera locale dovesse avviarsi verso la conquista di un vero potere di contrattazione collettiva, certamente la produzione di questi dispositivi verrebbe spostata altrove, in zone in grado di garantire condizioni più vantaggiose. Per il momento, Shenzhen rimane il luogo ideale per la produzione degli smartphone. Se facciamo qualche passo indietro nel processo di produzione, il quadro si fa ancor più fosco. Come tutti i dispositivi elettronici, la produzione dello smartphone richiede materie prime strappate alla Terra da un’industria estrattiva senza scrupoli. Il cobalto contenuto nella sua batteria agli ioni di litio viene estratto manualmente in Congo, spesso dalle mani di bambini; lo stagno usato nelle saldature che lo tengono insieme proviene molto probabilmente dall’isola indonesiana di Bangka, dove la falda acquifera è stata irrimediabilmente contaminata, il 70 per cento della barriera corallina è stato distrutto dai deflussi minerari, e dove in media un minatore alla settimana muore sul lavoro. I danni causati dai processi di estrazione investono quasi tutto un emisfero terrestre, mutilando sempre più vite, comunità umane ed ecosistemi naturali. Corsi d’acqua inquinati, bambini nati morti e diagnosi di cancro: anche questo diventa parte della trasformazione della vita quotidiana che lo smartphone ha determinato – almeno per alcuni di noi. In un altro contesto questi fatti ci farebbero riflettere, ma non sembra essere così quando si tratta dello smartphone».
Il cobalto di cui parla Greenfield è uno dei cosiddetti metalli rari, che si trovano in natura in piccolissime quantità, difficilissimi da estrarre e da trattare. Questi materiali, grazie alle loro particolari proprietà, sono fondamentali per tutte le tecnologie alla base delle “rivoluzioni” digitale e green, nonché per quelle belliche di punta: dagli smartphone alle infrastrutture per le telecomunicazioni, alle auto ibride ed elettriche, alla produzione di energia da fonti “rinnovabili”, ai missili “intelligenti”. Le procedure per estrarre le quantità – in crescita verticale – di metalli rari rese necessarie dalla diffusione di queste tecnologie e per separarli, utilizzando sostanze altamente nocive, dagli altri materiali, spesso radioattivi, ai quali in natura si trovano mescolati in proporzioni minime, sono devastanti per l’ambiente e per gli abitanti dei territori che si trovano dal lato sbagliato della transizione energetica e digitale. Come a Baotou, in Mongolia Interna (Cina), dove gli abitanti di villaggi soprannominati “villaggi del cancro” respirano, bevono e mangiano le scorie tossiche raccolte in un gigantesco bacino artificiale nerastro, morendo come mosche. Inoltre, la corsa all’accaparramento di questi metalli scatenata dalla loro crescente importanza strategica unita alla loro scarsità prepara le guerre a venire (un’esposizione più dettagliata di queste questioni è reperibile in La guerra dei metalli rari. Il lato oscuro della transizione energetica e digitale di Guillaume Pitron, Luiss, 2019, di cui consigliamo la lettura). Se a tutto questo aggiungiamo la crescita esponenziale della quantità di energia elettrica richiesta dalla società digitale per l’elaborazione dell’intera realtà ridotta a dati, e le montagne di rifiuti elettronici generati dall’obsolescenza, programmata e non, dei dispositivi, c’è davvero da pensare che l’impatto fisico del capitalismo “sostenibile” possa arrivare a farci rimpiangere l’età dei combustibili fossili (d’altronde, in tema di transizione energetica, in principio fu il nucleare…).
Tecnologia e razzismo
Come scrivono i compagni di rompere le righe nell’articolo Il tallone di silicio. Sul rapporto fra tecnologia, guerra e razzismo, in Calusca City Lights (a cura di), Lo spillover del profitto. Capitalismo, guerre ed epidemie, Colibrì, 2020, «a far sì che non siano la Lombardia, la Baviera o l’area di San Francisco a subire gli effetti devastanti [dell’estrattivismo di cui sopra] non è un accidente della storia, bensì il portato diretto della divisione internazionale del lavoro»: «La critica radicale della tecnologia e la critica radicale del razzismo di Stato sembrano procedere separate o tutt’al più giustapposte. Secondo noi, vanno invece intrecciate, in quanto elementi di contrattacco allo stesso processo di ristrutturazione del dominio e del controllo. In tal senso, ci pare decisivo cogliere l’elemento spaziale e geografico dell’accumulazione tecnologica. Lo sviluppo diseguale di aree e territori non è affatto il lascito di una sorta di preistoria della globalizzazione capitalistica, ma un elemento centrale, strutturale della sua espansione. Lo spazio della merce (a livello mondiale e negli stessi territori metropolitani occidentali) è contemporaneamente astratto e gerarchizzato. I ruoli e le prerogative che il dominio assegna agli esseri umani (e ai loro ecosistemi) corrispondono ai ruoli e alle prerogative assegnati ai territori che essi abitano. In tal senso il razzismo non è una sorta di escrescenza politico-ideologica, orrida e purulenta ma asportabile per via cultural-educativa, ma qualcosa che sgorga dalla divisione internazionale del lavoro, un elemento che caratterizza ab origine la filosofia del Capitale, come emblematicamente dimostra l’intera storia del “razzismo sistemico” del superpotente Stato nordamericano; e le nuove tecnologie non superano questo “peccato originale” della società in cui viviamo, bensì lo aggravano. Flessibilità produttiva, robotizzazione e informatizzazione, delocalizzazione, brutale sottomissione delle aree di incetta delle materie prime, riduzione pianificata del valore della forza-lavoro: a questi processi, cominciati nella seconda metà degli anni Settanta e oggi compiutamente dispiegati, le “tecnologie radicali” imprimono, sotto il manto della connessione universale, le caratteristiche di uno scontro ultimativo fra merce e corpi, fra organizzazione tecnica e natura, fra capitale e specie umana, fra incedere trionfale dell’inorganico e resistenza dell’organico. Ma sarebbe del tutto fuorviante pensare lo spazio del dominio come lineare. Dietro l’apparente incorporeità delle nuove tecnologie e dei loro prodotti di massa risuona ancora lo scarpone del giogo neo-coloniale e della segregazione».
Se l’estremo approdo della tecnologizzazione è l’avvicendamento dell’umano con il transumano (impianto di protesi tecnologiche, upload della mente su supporti digitali…), passando da quello del biologico con il biotecnologico (procreazione tecnologicamente assistita, manipolazioni genetiche…), anch’esso «segue precise linee di classe, di genere e di “razza”»: «cosa fa chi non emigra, non lavora per Nokia o Monsanto e non viene incarcerato? Se si tratta di una donna, e questa vive in India (in particolare nelle vaste zone dove è stata dismessa la produzione tessile, a sua volta impiantata dopo l’espulsione dalle campagne di centinaia di migliaia di contadini), diventerà un ingranaggio della “rendita riproduttiva” (proprio così, come si parla di “rendita petrolifera”) affittando il proprio utero per la “maternità surrogata”. Grazie ai servizi di una sorta di clinica mondiale, il “capitale genetico” potrà essere bianco (con gli ovociti acquistati per 200 euro da una donna rumena), mentre l’utero può essere anche indiano (per via di prezzi ancora più bassi che nell’Est europeo), dal momento che la gestazione non toglie “bianchezza” al nascituro. Ecco come ristrutturazione capitalista, nuove tecnologie e razzismo s’intrecciano efficacemente, prima ancora che una teoria razziale complessiva ne riattivi sul piano ideologico la presa sociale. Per ora bastano le “dinamiche geografiche” dei bisogni e del profitto. Lo stesso vale per il “lavoro rigenerativo”, cioè il mercato di tessuti per la ricerca sulle cellule staminali, e per la sperimentazione di nuovi farmaci. Proletarie di nuovo tipo, centinaia di migliaia di donne non hanno da vendere che le facoltà riproduttive e auto-generative del proprio corpo. Chi può contare solo su un corpo senza “capitale riproduttivo”, e non possiede nemmeno uno sperma quotato nelle banche del seme (dove si valutano colore della pelle, classe sociale e titoli di studio), potrà diventare materia grezza su cui sperimentare i nuovi farmaci, com’è il caso delle centinaia di migliaia di afroamericani e di latinos che negli Stati Uniti fanno le cavie per lavoro».
Anche il razzismo “soggettivo” più o meno esplicito è intrecciato con la tecnologizzazione della vita: «La potenza che produce la mancanza di indipendenza, a sua volta fonte rinnovabile della stupidità rancorosa e manipolabile, è una fabbrica di normòtipi che aspirano unicamente al comfort. Lo straniero povero non viene odiato soltanto in quanto concorrente nel mercato del lavoro o in quanto ci ricorda con la sua presenza che siamo tutti sradicati dal mondo e da noi stessi, ma anche perché le sue condotte – trovare un posto dove dormire, spostarsi senza risorse economiche, mangiare per strada, sostare nei parchi – sono meno mute, cioè meno garantite e mediate da un’organizzazione di atti che si compiono quasi da sé».
La guerra che viene
Dietro la corsa all’accaparramento delle risorse e la divisione internazionale del lavoro c’è la guerra, e uno dei campi di applicazione del 5G e delle tecnologie collegate è proprio quello militare: «una guerra che alimenta la guerra». Come riassumono gli autori di Guerra digitale, le innovazioni negli armamenti e nelle tecniche belliche vanno «dagli attacchi informatici alle reti energetiche o dei trasporti del paese nemico alla rivoluzione tattica che si annuncia sui teatri di combattimento. Anche la condotta della guerra terrestre è destinata a essere rivoluzionata dai veicoli a guida autonoma, dai suoi droni intelligenti, dai sommergibili d’attacco senza equipaggio, dall’equipaggiamento tattico di soldati che s’interfacciano con sistemi d’arma guidati dall’intelligenza artificiale».
È improbabile che il destino di queste armi sia quello di rimanere confinate ai campi di battaglia dei conflitti internazionali. Un esempio in questo senso lo riporta Grégoire Chamayou in Teoria del drone. Principi filosofici del diritto di uccidere (DeriveApprodi, 2014): «Come sempre, tutto comincia dalla periferia, dallo straniero e dalle frontiere. Si legge sui giornali, nella primavera del 2012: “Un sistema di sorveglianza all’ultimo grido, chiamato Kestrel, è stato testato quest’anno durante un’operazione portata avanti alla frontiera tra gli Stati Uniti e il Messico”. Si tratta di un pallone-drone, una specie di zeppelin equipaggiato di videocamere che “non si accontenta di fornire immagini in tempo reale agli operatori ma che registra, memorizzandoli, tutti gli eventi”. Dopo un mese di test, la polizia di frontiera ha annunciato l’intenzione di acquistare l’apparecchio. Un dirigente della ditta conclude: “Pensiamo vi sia un importante mercato interno”. […] Altro ritaglio di giornale, nello stesso periodo: l’ufficio dello sceriffo di Montgomery Country, a nord di Houston, Texas, annuncia di aver acquistato un drone “Shadow Hawk” e si dichiara “disponibile all’idea di munire l’apparecchio di armi non letali quali gas lacrimogeni, pallottole di gomma e di armi tipo Taser”».
Bisogna considerare che questi sviluppi si inseriscono in un contesto, come quello degli ultimi trent’anni, nel quale civile e militare si confondono sempre di più, all’insegna di una radicale asimmetria – di derivazione coloniale – che all’esterno dei confini statali, nella guerra divenuta operazione di polizia internazionale, sottrae al nemico i “diritti” che gli erano propri (uguaglianza giuridica dei combattenti, possibilità di difendersi legittimamente) per trasformarlo in terrorista, mentre all’interno, come ricordano i compagni di rompere le righe, vige quello che Günther Jakobs ha definito diritto penale del nemico: una parte della popolazione perde i caratteri di cittadino al quale anche nel momento in cui infrange la legge spetta godere delle garanzie dello stato di diritto. In quanto nemico dell’ordine sociale, può – e deve – essere combattuto senza esclusione di colpi.
A questa asimmetria, la tecnologizzazione associa un’ulteriore asimmetria nelle condizioni di percezione degli effetti della guerra: se la deresponsabilizzazione derivante dalla capacità tecnica di uccidere a distanza e dalla parcellizzazione delle mansioni nella complessa macchina bellica è una storia che viene da lontano, ora, come evidenzia Chamayou, siamo alla radicale distanza che separa il colonnello americano che racconta come nel corso della stessa giornata «passi da lanciare un missile ad accompagnare tuo figlio alla partita di calcio» dalle testimonianze degli abitanti del Pakistan nord-occidentale, che raccontano delle conseguenze anche psicologiche dell’«era dei panopticon volanti e armati»: «Ci sorvegliano costantemente; sono sempre sopra di noi e non si sa mai quando colpiranno»; «Tutti hanno continuamente paura. Quando ci riuniamo per fare una riunione abbiamo sempre paura di essere colpiti. Quando si sente un drone girare in cielo, tutti sanno che può colpire. Abbiamo sempre paura, come un chiodo fisso»; «Ho sempre i droni in testa. Mi impediscono di dormire. Sono come le zanzare. Anche quando non li vedi, li senti e sai che sono lì»; «I bambini, gli adulti, le donne, hanno tutti il terrore… gridano di terrore»; «Molti hanno perso la testa […] si sono chiusi in una stanza. Proprio come in prigione: sono prigionieri, rinchiusi in una stanza».
Dietro le decisioni sulle esecuzioni “chirurgiche” – con abbondante contorno di danni collaterali – portate a termine dai droni statunitensi nella guerra al terrore, ci sono tecniche – fatte proprie anche dal marketing per confezionare messaggi promozionali “su misura” – note come analisi dei pattern di vita: «Si scannerizzano le immagini per trovare nella massa delle attività, quegli eventi pertinenti per lo sguardo securitario. Questi ultimi si distinguono per la loro anomia, per la loro irregolarità. Ogni comportamento che sfugge alla trama delle attività abituali definisce una minaccia. […] L’individuazione automatica dei comportamenti anormali continua poi attraverso la predizione delle loro possibili evoluzioni. A partire dai tratti caratteristici di una sequenza nota individuati in una data situazione, gli analisti ritengono di poter inferire in maniera probabile, prolungandone le linee, le traiettorie future e di poter intervenire per impedire che si verifichino».
Secondo Chamayou, attraverso strumenti come questi, fino alla prospettiva di «robot capaci di esercitare la forza letale senza controllo o intervento umano», «la centralizzazione del comando – anche se questo ormai passasse per specificazioni programmatiche anziché per ordini – assume così proporzioni smisurate, poiché decidere del valore di una sola variabile permette, in una sola decisione sulla decisione, fissando i parametri di tutte le decisioni automatiche future in una sequenza data, di decidere in una sola volta dello svolgimento di un’indefinita miriade di azioni future. Fissare il valore di una specificazione del programma equivale, in forma molto più efficacemente centralizzata rispetto a un insieme di singoli ordini, di [sic] firmare una condanna a morte replicabile all’infinito». Si tratta del punto d’arrivo del percorso che «ha aumentato il peso della guerra ad alta intensità di capitale: rottura definitiva con il modello della coscrizione, crescente utilizzo di truppe private, sviluppo di armi per la guerra a distanza. Scompare il vecchio modello dell’“esercito dei cittadini” a vantaggio di quello di un esercito di mercato». Il risultato di queste mutazioni è stato «quello di ridurre la dipendenza materiale dell’apparato di Stato dal lavoro militare e quindi la sua dipendenza sociale dai corpi che costituiscono questa forza lavoro», riducendo così anche le possibilità e le conseguenze di una loro eventuale insubordinazione. «Il sogno è costruirsi una forza senza corpo, un corpo politico senza organi umani – in cui i vecchi corpi irreggimentati dei sudditi siano rimpiazzati da strumenti meccanici che ne saranno, rigorosamente, gli unici agenti. L’apparato di Stato, una volta diventato un apparato, disporrà così di un corpo corrispondente alla sua essenza: il corpo freddo di un freddo mostro. […] Eppure, giunto a questo stadio, il suo destino evidente potrebbe anche essere quello di finire dallo sfasciacarrozze, come un qualunque pezzo di ferro vecchio».
Come ha scritto qualcuno, la rete 5G e le tecnologie collegate (e le compagnie e gli enti che le promuovono, aggiungiamo) dipendono da «un’infrastruttura fisica che può essere attaccata in vari modi. C’è chi si è opposto all’installazione di nuove antenne occupando i cantieri, come c’è chi in diverse parti d’Europa ha scelto di dare alle fiamme i ripetitori. Se la rete 5G invaderà ogni ambito della nostra vita, ciò significa che i modi e i luoghi per sabotare questo progetto sono infiniti. Sta a noi aguzzare l’ingegno»…