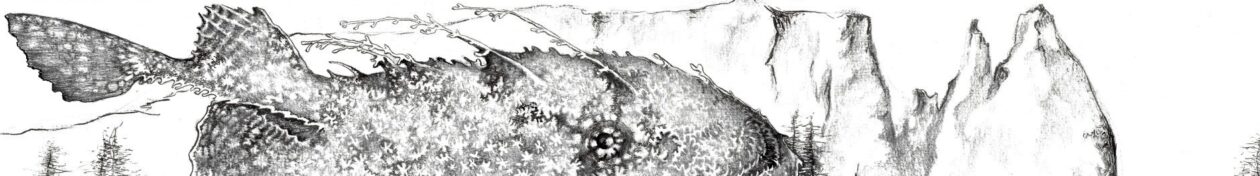L’annunciata apertura di un CPR anche in Sudtirolo questa volta sembra concretizzarsi. Qui come a livello nazionale osservando giornali e tv sembra di trovarsi di fronte a una misura inedita del governo Meloni; la memoria di oltre due decenni di storia di queste strutture di detenzione in Italia appare scarsa o nulla.
Come dovrebbe essere noto, i lager per senza documenti nel nostro paese nascono nel 1998 come CPT (Centri di Permanenza Temporanea) per mano del governo di centrosinistra guidato da Romano Prodi, con la legge firmata da Livia Turco e Giorgio Napolitano – e il sostegno tra gli altri anche di Verdi e Rifondazione Comunista. Da allora, una storia di allungamenti e accorciamenti dei tempi massimi di detenzione, cambi di nome (dal 2008 CIE, Centri di Identificazione ed Espulsione), chiusure grazie alle rivolte delle persone recluse e da ultimo la loro riapertura col nome di CPR ad opera del ministro Minniti – altro governo di centrosinistra. D’altronde anche a livello locale il dibattito sul CPR ha reso evidente come, appena al di sotto del velo di retorica, destra e sinistra parlino lo stesso linguaggio, quello grondante sangue delle soluzioni tecniche.
Altrettanto noto dovrebbe essere che chi viene rinchiuso in questi centri non deve scontare una condanna per un reato commesso, ma ci si trova per la propria condizione di irregolare, indesiderato sul territorio (uno slittamento, dalla punizione per quello che si è fatto alla punizione per quello che si è, che come molti altri aspetti del sistema di gestione dell’immigrazione tende ad estendersi al resto della società).
Anche le condizioni all’interno di questi luoghi dovrebbero essere note, avendo raggiunto livelli di disumanità tali da essere denunciati anche dai democratici e dai principali mezzi d’informazione: spazi angusti, condizioni igieniche intollerabili, assenza pressoché totale di assistenza sanitaria, ostacoli alla comunicazione con l’esterno e alla difesa legale, cibo visibilmente avariato, psicofarmaci distribuiti in quantità e perfino nascosti nei piatti per sedare i reclusi, interventi dei reparti mobili a soffocare le proteste, umiliazioni, pestaggi e torture. Le morti, i tentativi di suicidio e gli atti di autolesionismo non si contano, anche nel lager di Gradisca, dove regolarmente vengono condotte le persone rastrellate nelle strade di Bolzano.
Quello che tende a rimanere in ombra nelle letture tutte appiattite sulla «cattiveria» del governo di destra – o del Landeshauptmann di turno – è la funzione dell’intero sistema dell’«accoglienza», e dei CPR al suo interno, al netto dei progressivi inasprimenti legislativi. Un sistema di controllo, disciplinamento e selezione, per «integrare» quei pochi che dimostreranno di esserne meritevoli, rinchiudere e deportare i meno docili, sfruttare tutti – sotto la costante minaccia di scivolare al gradino inferiore.
Inseguendo le sue esigenze di valorizzazione e spacciando “soluzioni” tecniche e militari che continuano ad aggravare i problemi in una spirale vertiginosa, il capitale ha ormai distrutto le condizioni di una vita sostenibile in gran parte del pianeta, sradicando milioni di persone. Di fronte a ciò, si è dotato di un sistema di gestione delle frontiere che permetta di controllare i flussi e allo stesso tempo di mettere al lavoro le braccia di cui ha bisogno nelle condizioni di massima ricattabilità possibile – un sistema del quale il fatto che ci troviamo in uno stato in guerra non potrà che esasperare la ferocia.
Ma come appariva chiaro sin dall’inizio, la logica di premialità e deterrenza che informa il sistema della cosiddetta accoglienza – compresa quella «diffusa» –, e di cui la detenzione amministrativa non è che l’infamia più estrema, ha tracimato investendo l’intera società, potenziata dai mezzi tecnici forniti dalla digitalizzazione. Da questo punto di vista, il green pass è stato solo l’antipasto della vita a punti che si profila, in cui libertà di movimento e accesso ai servizi dipenderanno sempre più in automatico dall’aver dimostrato di corrispondere ai modelli di comportamento suggeriti. I prossimi passaggi ce li porteranno le prossime emergenze, a partire da quella climatica. (Un inciso: se almeno una parte della maggioranza che sull’esistenza di luoghi come i CPR non ha nulla da eccepire dovesse mai cambiare idea, questo non succederà perché dimostreremo loro che sono disumani, ma perché dimostreremo loro che sono una minaccia per la libertà – e le condizioni materiali – di tutte/i).
Detto questo, se da una parte ci sembra necessario chiarirsi le idee su questi aspetti, dato che limitarsi a un’ottica di mero antirazzismo e difesa dei cosiddetti diritti umani sarebbe a dir poco miope, dall’altra la semplice possibilità dell’esistenza di un luogo in cui si tengono rinchiuse delle persone in attesa di essere deportate dovrebbe bastare e avanzare per far ribollire il sangue e per decidere di provare a impedire la sua apertura. «Ma che significa affermare, in un’epoca in cui le parole sembrano aver perso ogni senso e ogni forza, che una cosa è inaccettabile? Quante volte si è accettato ciò che si dichiarava di non poter accettare? Provare ad abbattere le frontiere è anche un impegno a non accettare l’inaccettabile»: così si scriveva, tra l’altro, nel testo di indizione del corteo al Brennero del 2016 contro la costruzione di un muro anti-migranti annunciata dal governo austriaco. Per quella giornata, la sentenza d’appello ha distribuito condanne per più di 120 anni, che se dovessero essere confermate in Cassazione porterebbero in carcere decine di compagne/i. E ancora: «Siamo pochi, lo sappiamo. Vorremmo tuttavia suggerire un certo modo di essere internazionalisti oggi. Centinaia di migliaia di donne e di uomini giungono alle frontiere dopo viaggi estenuanti, conoscendo a malapena le zone dove passano o dove arrivano; ignorano quanti poliziotti troveranno, se ci saranno fiumi da guadare e quanti ne usciranno vivi. Eppure partono, con la caparbietà della disperazione, e con caparbietà in tanti si battono, anche a mani nude. Noi, che mangiamo tutti i giorni, che siamo mossi da un ideale e non dalla paura cieca o dai morsi della fame, vorremmo proprio noi delle garanzie di riuscita prima di lanciarci all’assalto di questo mondo e dei suoi reticolati? Se vogliamo che crolli la frontiera tra loro e noi, dobbiamo a nostra volta salpare dalle terre note e familiari».
La storia degli ultimi decenni da un lato racconta che «i CPR si chiudono col fuoco» non è uno slogan ma il preciso insegnamento delle lotte delle persone recluse che questi lager li hanno chiusi davvero e a più riprese. Una storia di evasioni e rivolte che continuano anche mentre scriviamo e che negli scorsi mesi hanno portato ancora una volta alla chiusura del CPR di Torino reso inagibile dalle fiamme appiccate dai reclusi.
Dall’altro, dimostra che, se c’è qualcosa a livello di mobilitazione che può incidere, non è certo la pressione politico-mediatica sui decisori per indurli ad attuare misure più “umane”, ma gesti concreti che rendano la vita difficile a chiunque collabori, in qualsiasi modo, alla gestione di questi centri – e della macchina di cui sono un ingranaggio –, fino a convincerli che il gioco non vale la candela (non si può non ricordare a questo proposito lo stillicidio di azioni, dalle iniziative pubbliche di denuncia agli attacchi incendiari, che in tutta Italia hanno colpito Poste Italiane per la sua complicità nelle deportazioni dagli allora CIE attraverso la compagnia aerea Mistral Air).
Scrollarsi di dosso l’equivoco di vedere nelle istituzioni un interlocutore, individuare i nemici, attaccarli nei modi che ognuna/o sente più congeniali. Il minimo che si possa fare se davvero vogliamo «che crolli la frontiera tra loro e noi».