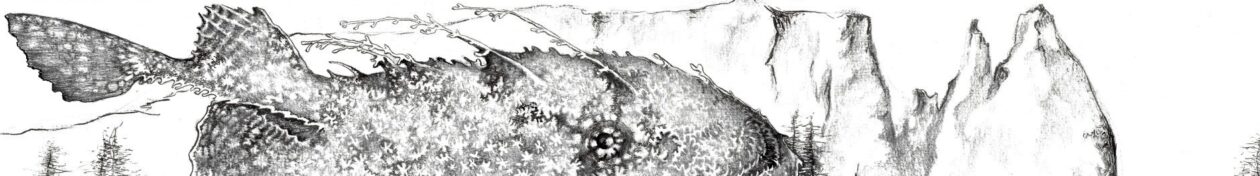Nelle scorse settimane fra l’Alto Adige (Val Pusteria) e le Dolomiti bellunesi si è svolta l’ennesima esercitazione militare, che ha visto truppe italiane, francesi e statunitensi addestrarsi “al combattimento in montagna e aree caratterizzate da climi rigidi” (“come in un film d’azione”, titola l’Alto Adige). Solo pochi mesi fa si era svolta un’esercitazione analoga, a margine della quale in un convegno a Bolzano si era presentato lo scioglimento dei ghiacci dell’Artico come “un’opportunità” per le rotte commerciali e per l’accaparramento di materie prime, e un fattore di nuova centralità strategico-militare dell’area, alla quale prepararsi. Fra i partecipanti, l’amministratore delegato della bolzanina Iveco, in odore di nuove commesse. Se il presidio antimilitarista di giovedì e la critical mass promossa sabato dall’Assemblea cittadina contro le guerre e per il disarmo sono stati un’occasione, anche, per sottolineare cosa significhi vivere in uno stato in guerra e quanto sia urgente sabotarlo, la seconda parte del testo che segue prova ad allargare lo sguardo sulla faccia più in ombra della guerra che avanza, a partire da Bolzano.
In un paese in guerra – come è già il nostro – al peggioramento delle condizioni di vita corrisponde l’aumento della ferocia contro il nemico interno: uno stato in guerra è uno stato che si assume la responsabilità di condannare a morte un prigioniero anarchico, Alfredo Cospito, in sciopero della fame da ormai cinque mesi contro il regime di annientamento del 41 bis e l’ergastolo ostativo (quando si sottolinea, giustamente, la brutalità di un regime come quello iraniano sarebbe sempre il caso di ricordare che anche in Italia lo stato tortura e uccide i rivoluzionari); uno stato in guerra è uno stato che condanna a ventotto anni di carcere un altro anarchico, Juan, per un attacco a una sede della Lega in cui non ci sono stati né morti né feriti (per il prossimo 28 marzo è prevista la sentenza di appello, preceduta il 25 da un corteo di solidarietà a Venezia); uno stato in guerra è uno stato in cui il tribunale di Bolzano, l’altro giorno, ha condannato in appello a complessivi 129 anni di carcere (fino ad oltre 5 anni a testa) decine di compagni che nel 2016 parteciparono al Brennero al corteo contro la costruzione di un muro anti-migranti.
Uno stato in guerra è anche uno stato che istituisce l’allucinante Comitato per la cultura della Difesa, presieduto dal ministro della guerra Crosetto e composto da intellettuali di regime che dovrebbero “cambiare la percezione dello Strumento Militare nazionale rispetto al passato” e, in un completo rovesciamento della realtà, “tutelare la correttezza del dibattito pubblico, promuovendo la verità dei fatti” (con quale faccia questi figuri parlano della propaganda russa?).
Uno stato in guerra si regge sempre di più sull’emergenza come dispositivo di governo, che viene da lontano ma che negli ultimi tre anni è stata messa a punto a livelli inediti con il confinamento e l’imposizione di una sperimentazione biotecnologica di massa e di un certificato digitale di obbedienza per poter circolare e perfino per poter lavorare. Un vero e proprio esperimento sulla resilienza della popolazione di fronte a restrizioni inedite della libertà, e non c’è motivo di dubitare che le prossime emergenze, a partire dalla guerra e da quella idrica che si profila, saranno gestite con la stessa logica: radicale delegittimazione di qualsiasi dissenso, criminalizzazione dei comportamenti individuali, assenza di discussione sulle responsabilità dell’apparato e sulle questioni di fondo, progressisti in prima linea con l’elmetto in testa a dare la caccia al disertore.
Di fronte alla concreta prospettiva di un conflitto dispiegato fra le maggiori potenze mondiali è ogni giorno più urgente – insieme alla solidarietà internazionalista, in primo luogo con i disertori di ogni campo – sabotare con ogni mezzo l’unità del “nostro” fronte, quello occidentale, rompendo quella cappa di piombo che è la pace (o coesione, per i più al passo coi tempi) sociale. Anche perché la storia insegna che la repressione colpisce più duro quando il conflitto sociale è più debole, non viceversa. Il miglior antidoto al senso di impotenza alimentato dalla dismisura degli eventi che ci troviamo di fronte è individuare e non lasciar lavorare in pace – ognuno coi metodi che sente più congeniali – il nemico più a portata di mano.
Se nella nostra città la mente non può che correre all’Iveco, sarebbe il caso di cominciare a scorgere anche altri nemici meglio camuffati. Casualmente proprio di fronte allo stabilimento Iveco di Bolzano sorge il NOI Techpark, “parco tecnologico” in cui convivono laboratori dell’università e di altri enti di ricerca (e dove è in costruzione la nuova facoltà di ingegneria), start-up e imprese che si appoggiano agli spazi messi a disposizione per fare ricerca e sviluppo. Proprio qui nei giorni scorsi il presidente della Provincia Kompatscher ha presentato i settori considerati strategici nei quali le attività di ricerca e l’industria altoatesina dovrebbero ulteriormente specializzarsi nei prossimi anni: tecnologie green, settore Food & Health (e per la “salute” vengono citate in particolare scienze omiche, basate su raccolta e analisi di dati sui processi biologici, e “medicina di precisione”), tecnologie digitali (in particolare internet delle cose e intelligenza artificiale), automotive (la succursale del NOI a Brunico, la cui apertura è prevista a breve, sarà interamente dedicata a questo settore) e automazione.
Ma cosa c’entra questo “hub dell’innovazione”, come viene presentato, coi dirimpettai produttori di mezzi corazzati (e di camionette per la celere, se servissero ulteriori dimostrazioni del fatto che guerra esterna e guerra interna sono legate a doppio filo)?

Basta scorrere l’elenco delle startup e delle aziende ospitate per farsi un’idea del tipo di mondo che questo fiore all’occhiello della ricerca e dell’economia altoatesine contribuisce ad apparecchiarci: fra l’altro, si parla di “robotica avanzata e intelligenza artificiale” appplicate all’agricoltura, di sistemi di crescita delle piante “indipendente dal luogo e dal tempo” e “altamente automatizzata”, di prodotti e servizi digitali per il settore delle cure ospedaliere, di piattaforme digitali per l’apprendimento nelle scuole superiori, di un “barometro digitale dell’umore” che raccoglie dati “sul livello di impegno” dei dipendenti delle aziende per poi supportare “l’implementazione di strategie d’azione”, di valutazione della “performance emotiva” attraverso strumenti di “Sentiment Analysis”, di “monetizzazione dei flussi di dati provenienti da smart device in conformità con le leggi sulla privacy”, di “incubatori di start-up” innovative nel campo delle scienze della vita, di tecnologie legate all’idrogeno come combustibile e ai sistemi di approvvigionamento energetico, di droni per la sorveglianza… Non manca ovviamente un occhio all’ulteriore sviluppo del turismo, fra yachts ecosostenibili e tecnologie per gli sport invernali, come se il territorio altoatesino non ne fosse già abbastanza devastato (a proposito, sarebbe il caso di iniziare a guardare imprese come Leitner e TechnoAlpin, tanto per citare solo i due nomi più “illustri”, con occhi non troppo diversi da quelli che rivolgiamo all’Iveco).
Appena sotto la superficie di quello che viene presentato come un florilegio di soluzioni brillanti e sostenibili, si celano le tendenze fondamentali della ristrutturazione capitalista in corso. Se dovrebbe essere ormai una consapevolezza diffusa il fatto che la digitalizzazione – oltre a comportare un atroce immiserimento del rapporto con la realtà – è un disastro ambientale di proporzioni globali, viste le conseguenze ecologiche – e neocoloniali, e belliche – della sua crescente voracia di materie prime, energia e acqua, l’avanzata delle cosiddette tecnologie convergenti (nanotecnologie, biotecnologie, informatica e scienze cognitive) può ben essere letta come una guerra all’umanità – e alle altre specie.
Di fronte a un sistema che per sopravvivere a se stesso produce condizioni ambientali e sociali sempre più nocive e insopportabili e tende sempre più alla guerra, per non dover mettere in discussione le cause si lavora ad adattare il vivente a queste condizioni (questo significa resilienza). Da una parte, con un controllo digitale sempre più capillare e automatizzato, per valutare e premiare o punire in tempo reale i comportamenti più o meno conformi alla logica del sistema. Dall’altra, con le biotecnologie, arrivando a manipolare i processi biologici fondamentali. La conseguenza è quella di espropriare nel modo più radicale gli individui della facoltà di autodeterminarsi, rendendoli in prospettiva dipendenti persino per la mera sopravvivenza biologica (nutrirsi in un ambiente definitivamente degradato, o sopravvivere a virus ingegnerizzati per scopi militari, tanto per fare un paio di esempi) da un apparato che causa disastri e fornisce false soluzioni che li aggravano ulteriormente.
Se vogliamo difendere la possibilità di lottare contro un futuro di guerra e miseria, la diserzione di studenti e ricercatori non è meno auspicabile di quella di chi assembla mezzi militari o è costretto a vestire una mimetica; non lasciar lavorare in pace luoghi come il NOI non è meno urgente che sabotare l’industria bellica.